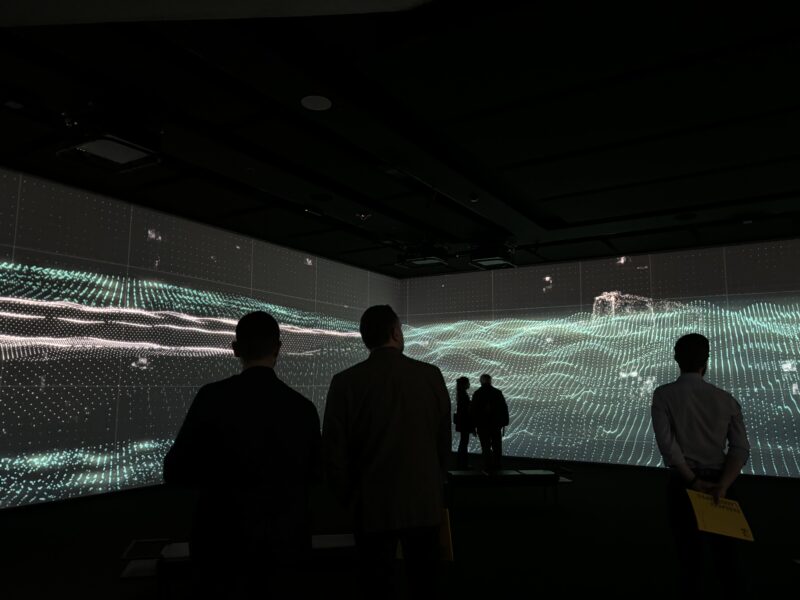“Tendo spesso, a quanto pare, a cercare modelle che mi somigliano. Nelle mie fotografie racconto di me, dei miei dolori, delle esperienze che ho vissuto. È stranissimo, l’ho scoperto attraverso gli altri, vedevano le mie foto e pensavano fossero autoritratti”
Era Enesi – a cui lei aggiunge Vento, il significato del suo nome albanese – ha 29 anni, è nata a Tirana, ma vive in Italia da quasi tutta la vita: “Sono arrivata clandestinamente, ho una vita un po’ particolare”. Era dal 2015 fotografa nudi femminili, anche se il suo è stato un amore a prima vista quando aveva otto anni: “All’epoca i miei genitori erano tornati in Albania e ho vissuto a casa di amici di famiglia. Mi sono ritrovata in un mondo completamente diverso dal mio: una casa piena di fotografie, donne nude, libri, videocassette”. Qui, vede per la prima volta le opere di Helmut Newton, fotografo tedesco che fra anni Sessanta e Settanta rivoluzionò l’immagine femminile nelle riviste patinate. Le sue donne sono cariche di erotismo, per l’epoca sfacciato, ritratte in pose non convenzionali e – soprattutto – nude. “Ho dei genitori abbastanza rigidi, quindi quelle foto erano tutto quello che non potevo fare”.
A undici anni arriva la prima macchina fotografica, le classiche foto ai tramonti, ai riflessi, alle pozzanghere. Negli anni, matura la consapevolezza di voler spostare l’obiettivo. Frequenta una scuola a Milano e finalmente Era comunica ai genitori che il nudo è quello che vuole fare: “Ho iniziato ad appiccicare in camera mia tutti i nudi che facevo. Credo che si siano abituati a questa idea, a questo mio mondo, anche se non l’accettano ancora del tutto. Mi appoggiano, anche se dall’altro lato sono sempre lì a dirmi ‘ma forse è meglio che ti cerchi qualcos’altro’”. Del resto, non dirlo non è un’opzione: “Il nudo fa parte di me, non posso negarlo, non posso farlo diventare invisibile. Non provo imbarazzo, anzi ne sono orgogliosa. Che noia che il nudo venga ancora percepito come pornografico, non si può sentire nel 2022”.
Attraverso i corpi delle altre, le sue modelle che le somigliano, Era si racconta: la sua vita, le sue esperienze, i suoi dolori. Dolori che la accompagnano dalle prime mestruazioni, avute ancora bambina, a dieci anni. Dolori che da solo pochi mesi hanno un nome – vulvodinia – e forse se ne aggiungeranno altri: “Ho avuto la diagnosi a settembre, poi dovrò andare a Bologna per scoprire se ho anche endometriosi”.
La vulvodinia è una patologia che colpisce le donne in età riproduttiva, caratterizzata da dolore cronico all’ingresso della vagina e nella zona che la circonda – la vulva appunto – senza alcuna lesione visibile a giustificarlo. Come la maggior parte delle condizioni che riguardano le donne – più precisamente, le persone che hanno un utero – è conosciuta pochissimo: individuata per la prima volta nel 1880 dal ginecologo statunitense Theodore Gaillard Thomas, è poi scomparsa dai testi medici per un secolo e solo nel 2019 è stata inserita dall’Organizzazione mondiale della sanità nella classificazione internazionale delle malattie. La maggior parte delle persone che ne è affetta, lo sa da molto prima di ricevere una diagnosi ufficiale, che in media ci mette cinque anni ad arrivare.
Era non fa eccezione: “Da quattro o cinque anni peggioravo sempre di più. Ho fatto tantissime visite e cambiato altrettanti ginecologi: mi sembrava una follia”. L’ultima dottoressa l’ha liquidata con un messaggio, diceva che non sapeva cosa fare della sua candida. “Grazie ai social ho iniziato a informarmi sulla vulvodinia, mi sono riconosciuta in tutti i sintomi. Poi una ragazza come me affetta dalla stessa malattia mi ha consigliato degli specialisti”. Nonostante Era se lo sentisse, ricevere la diagnosi è stato un punto di rottura nel rapporto col suo corpo: “Ho smesso di fotografarmi. Ora che sto facendo delle cure, sto ricominciando ad amarmi e piano piano anche a fotografarmi. Sto cercando di dire ‘va bene, questo è e ci devo convivere’”.
Nelle sue foto, nei corpi ritratti – quelli delle altre e il suo, che però non espone nelle mostre – c’è la sua storia: lei da bambina, circondata da fotografie d’autore; la sua cameretta, tappezzata di donne nude; la conquista di aver fatto accettare il lavoro dei suoi sogni alla famiglia; il suo dolore. Una storia che sente che a Torino non viene capita: “Qua mi sento un po’ limitata, la mentalità è chiusa. A volte penso che non potrò mai diventare quello che vorrei in Italia, o forse a Torino”. Una consapevolezza che però diventa anche un motore: “Mi porta a voler fare di più. Voglio abbattere quel muro che c’è, questa sofferenza, questo soffocamento”.