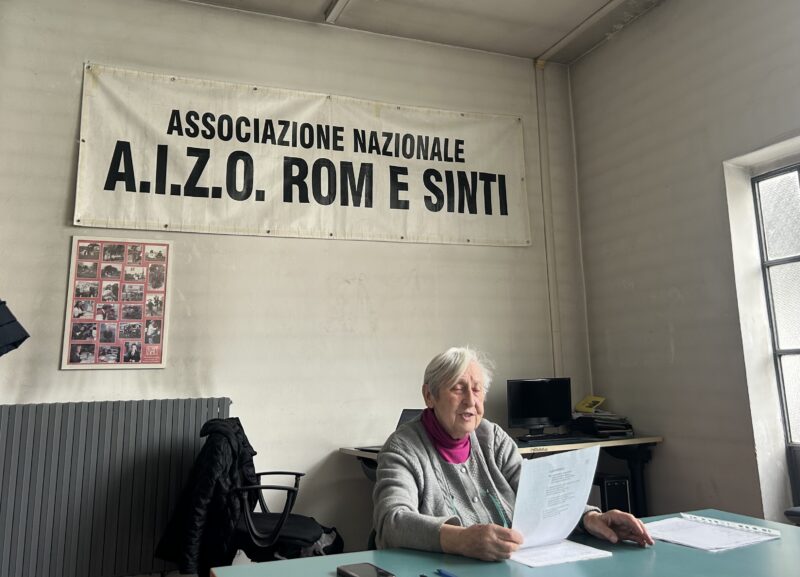Il paradigma del risiko è acqua passata, le nuove guerre non si combattono in un’arena di forze statali, ma a conti fatti pare anacronistico anche per il primo Novecento: “Basti pensare ai partigiani nella seconda guerra mondiale”. Stefano Ruzza, scienziato sociale e professore dell’Università di Torino, non ha mai amato il gioco del risiko: da bambino lo trovava poco più di un lancio di dadi, da studioso trova la sua rappresentazione della guerra inadeguata. “Le guerre post-2010 sono soprattutto guerre civili e si spiegano in primo luogo a partire da ragioni locali, piuttosto che attraverso il grande gioco internazionale – spiega Ruzza, citando poi un suo caso di studio – La Cina non ne sapeva niente del golpe in Myanmar. È sempre stata una guerra civile, fin dal 1947”.
La sua lectio per la Biennale democrazia 2025 di Torino, Nuove guerre. Dove, come, quando, perde l’ultima domanda e viene sostituita da “quante?”, dato che secondo Ruzza le nuove guerre sono semplicemente le guerre dell’oggi. Per rispondere, l’approccio scelto dal professore è l’analisi dei dati, a partire dall’Uppsala conflict data program (Ucdp), un programma di raccolta ed elaborazione gestito dall’università svedese di Uppsala. Attraverso questa lente quantitativa, Ruzza propone una critica ad alcune letture tipiche del Novecento: le guerre civili non sarebbero un’eccezionalità derivante dal crollo dell’Unione Sovietica, in quanto fenomeno da sempre presente nella storia dell’uomo. Inoltre, come evidenziano i grafici del think tank, il loro numero calò drasticamente dopo la caduta del muro di Berlino del 1989, per poi tornare a crescere dopo il 2010. “Il periodo della guerra fredda è stato troppo romanticizzato – commenta Ruzzo – Sono stati anni sanguinosi, anche se meno delle guerre mondiali”.
Ma perché la violenza organizzata è esplosa dopo il 2010? Per provare a rispondere, Stefano Ruzza si smarca dalle tesi del classico dell’autrice britannica Mary Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale. Secondo il professore, la politica dell’identità, su cui si concentra Kaldor, non è una peculiarità del ventunesimo secolo, in quanto non così diversa dai nazionalismi novecenteschi. Neanche il focus sull’economia di guerra globalizzata è ritenuto solido: “Già durante la guerra civile americana esistevano finanziamenti illeciti, basti pensare al bandito Jesse James, che con suo fratello derubava i treni per i confederati”. Ruzza preferisce partire dall’evidenza empirica delle “guerre più nuove”, che sono più numerose, perlopiù non statali e contano più morti: “Negli anni ’10 c’è stato un incremento dell’impegno militare in Iran e Afghanistan, la guerra civile in Siria, l’aumento dell’internazionalizzazione delle guerre civili e nei ’20 la troppo spesso dimenticata guerra civile in Etiopia, la guerra russo-ucraina e la ripresa del conflitto israelo-palestinese”.