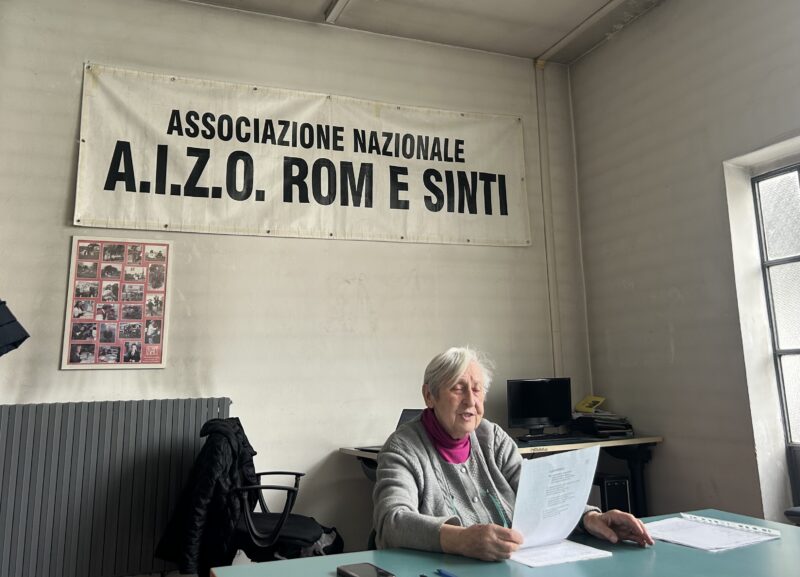Ad appena 80 anni dalla nascita del primo calcolatore elettronico, Maniac, prodotto dagli americani durante la Seconda guerra mondiale, ci troviamo immersi in un mondo completamente computerizzato. Come spiega Juan Carlos De Martin, professore di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, durante la lectio “Le Big Tech e la guerra” la vera computerizzazione del mondo è iniziata 25 anni fa, quando i computer sono diventati sufficientemente piccoli e connessi a internet. Questo processo è stato fagocitato da poche aziende, le Big Tech.
Dario Guarascio, professore di Politica economica all’Università La Sapienza di Roma, apre dunque la sua lectio al Polo del 900 parlando di una “storia di vecchie contraddizioni con una nuova veste tecnologica”. I conflitti, infatti, sono direttamente collegati al potere economico. E di potere economico, oggi, le Big Tech ne hanno eccome: sommandone la capitalizzazione in borsa si ottiene un valore che supera il Pil di Germania e Giappone, spiega Guarascio: “Se guardiamo poi alle spese di sviluppo, ai brevetti e alle pubblicazioni scientifiche scopriamo che le Big Tech, de facto, detengono il controllo dell’evoluzione della frontiera tecnologica”.
Ma quali sono le cause che hanno consentito una tale concentrazione di potere economico e tecnologico e in così breve tempo? “Il modello di business delle Big Tech – spiega Guarascio – è legato al nostro consenso alla profilazione dei dati. Per le piattaforme, i dati sono un vero e proprio bene, a esempio per la targhetizzazione della pubblicità. La digitalizzazione della vita ci parla anche di un processo innato al capitalismo, vale a dire la mercificazione di qualsiasi cosa”.
Questa vita digitale riguarda tutti noi: i singoli individui, le aziende, gli Stati. E proprio perché ci riguarda tutti da vicino è diventata pressoché irrinunciabile: “La microeconomia ci viene in soccorso e ci aiuta a spiegare questo meccanismo: quando i beni e i servizi hanno una natura reticolare, cioè numeri elevati di utenti, ne aumentano attrattività e costo percepito per l’abbandono di quel servizio”. Esattamente quello che accade con le piattaforme: le app di messaggistica istantanea, a esempio, sono oggi così diffuse che rinunciarvi implicherebbe disagi enormi per ciascuno di noi.
Quello che prende forma negli Stati Uniti dopo il crollo delle Torri gemelle l’11 settembre 2001 è un complesso militare-digitale: “L’egemonia americana deve fare i conti con un sistema globalizzato e interdipendente in cui gli Usa sono più deboli del previsto”. In questo contesto, tuttavia, gli apparati militari capiscono di avere al proprio fianco “soggetti con elevata capacità tecnologica, che possono diventare partner fondamentali: quella tecnologia può essere usata per la sorveglianza, per le sanzioni, per gli omicidi targhettizati”. Le Big Tech, infatti, posseggono elementi infrastrutturali di cui il governo non può fare a meno e su cui esse avevano investito, in controtendenza rispetto alle grandi imprese. Spiega Guarascio: “Non è una questione esclusivamente materiale: quando si controlla un’infrastruttura, si creano delle competenze legate a quella singola organizzazione molto difficili da replicare. È così che si diventa partner irrinunciabili”.
Oggi, infatti, le tecnologie delle Big Tech sono duali: “Sono vitali nel mercato privato e sempre di più anche in ambito bellico, per la sorveglianza, la repressione e i cyber-attacchi. Le tecnologie di intelligenza artificiale (Ia) si innestano sul cloud, sono dietro gli armamenti di nuova generazione senza il controllo dei quali non si vince una guerra”.
L’intelligenza artificiale, tuttavia, segna una discontinuità rispetto all’inizio dell’era della rete internet: la conoscenza di base era, allora, comprensibile per il settore pubblico, che aveva contribuito allo sviluppo di quelle tecnologie. Oggi, invece, gli elementi fondamentali dietro l’Ia generativa sono nelle mani delle Big Tech. Questo rapporto, tuttavia, è di “mutua dipendenza”: anche le Big Tech traggono beneficio, soprattutto in periodi di crisi economica, dagli elevati flussi di spesa militare per il digitale. “Inoltre, i profitti che le Big Tech ottengono sui mercati civili non sono nemmeno paragonabili a quelli con il settore militare, che inoltre apre loro le porte all’accesso a dati sensibili, le rende titolari di infrastrutture vitali” specifica Guarascio.
La mutua dipendenza non è però solo economica, ma anche strategica: “Come lo Stato non può fare a meno delle Big Tech, che sono la longa manus dell’apparato militare, così anche per le Big Tech è importante il rapporto con la politica. Basti pensare a quando, una settimana dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino, l’allora presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiese all’Unione europea di attenuare i vincoli del Data protection regulation e riattivare il trasferimento automatico dei dati verso gli Usa”.
Tutto questo accade, per altro, in aperta contraddizione con il principio ideologico sul quale erano nate le Big Tech: “Le piattaforme che hanno costruito la loro origine ideologica millantando distanza dal potere pubblico, soprattutto quello connesso alle attività militari, si sono messe l’elmetto e sono completamente attive nei territori di guerra”. Per Guarascio però la partecipazione ai conflitti non è solo un modo per acquisire centralità, ma anche per per usufruire di un contesto in cui testare e migliore le proprie tecnologie. “E questo non accade per le aziende che non si trovano in questi contesti bellici”.